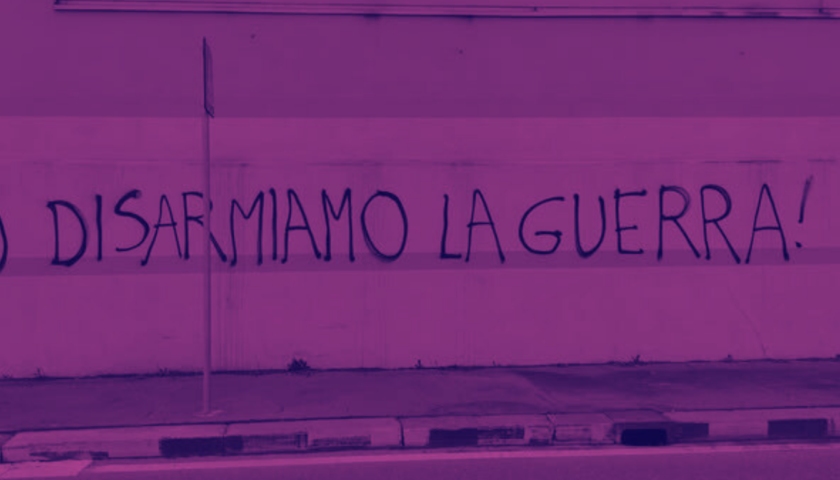Se sostenessi che nelle recenti elezioni presidenziali statunitensi avrei scommesso nella vittoria di Trump vi direi una grossa bugia. In buona sostanza, contavo sulla staticità dell’elettorato americano in favore dei democratici, anche se la figura di Hilary Clinton era assai debole. Le cose non sono andate così e Hilary, che ha attraversato il continente in lungo e in largo, avrebbe dovuto percepire il mutamento di umore. Non lo ha percepito e si è lasciata suggestionare dalle chiassose manifestazioni di consenso del suo ristretto entourage. Ma gli errori più gravi che ha commesso durante la sua campagna elettorale sono stati altri e decisivi. Il primo, forse quello determinante, è stato quello di arroccare il partito democratico sul fronte dei poteri costituiti; la sua vicinanza alle élite delle banche, di Wall Street e delle lobby è stata decisiva per spostare il voto degli americani. Altro errore è stato quello di non aver capito che l’elettorato nel suo complesso era stufo delle successioni dinastiche. Gli americani non avevano metabolizzato gli errori commessi da Bush padre e figlio e dai Clinton e avevano perfettamente intuito che la presidenza di Barack Obama aveva in qualche modo interrotto la successione dei multimiliardari che, di fatto, conducevano l’America verso incroci pericolosi. In questo senso Hilary Clinton era stata percepita soprattutto come moglie dell’ex presidente, senza margini di autonomia.
Terzo elemento di debolezza della candidatura Clinton, che non dipendeva da lei, era la gracilità e la precarietà della sua salute: un presidente della nazione più potente del mondo doveva essere capace di spostarsi rapidamente da una parte all’altra del globo. Da questo punto di vista gli americani avevano difficoltà ad accettare un presidente che era costretto a muoversi con al seguito un medico che la sostenesse ogni volta che scendeva dalla macchina presidenziale.
Tutti questi fattori hanno compattato, sotto la personalità assai discutibile di Donald Trump, tante volte volgare e poco credibile, un elettorato molto eterogeneo che andava dalla pancia dell’America profonda ai giovani senza futuro, dagli operai delle zone industriali al mondo contadino. Non sarà un elettorato facile da governare, come dimostrano le grandi manifestazioni che in molti Stati dell’Unione contestano la legittimità dell’elezione. In effetti la posizione di Trump non è delle più semplici; intanto ha contro una parte assai consistente del suo stesso partito, poi in suo favore non ha la maggioranza qualificata in Senato, potendo contare soltanto su 51 senatori a fronte dei 60 richiesti dalla normativa americana per l’approvazione delle leggi. Poi ancora la scelta dei collaboratori sarà certamente invisa ad un popolo che, nella sua maggioranza, è meno sprovveduto di quanto pensi chi lo governa, se – come sembra – prevarrà la deriva più oltranzista, xenofoba e sostanzialmente isolazionista.
Questo ci porta alla politica estera. Non risulta che Trump abbia viaggiato molto al di fuori degli Stati Uniti. In ogni caso è certo che non conosce nè i luoghi dove si svolgono gli eventi maggiori della contemporaneità, nè la diplomazia che quegli eventi è chiamata a regolare. In questo senso la scelta dei suoi collaboratori certamente non lo aiuta: Jeff Sessions (politico del Sud accusato di razzismo e non in conflitto con il KKK, assolutamente contrario alla concessione della cittadinanza ai lavoratori clandestini) come ministro della giustizia; il generale Michael Flynn (molto amico di Putin e titolare di una società di consulenza in rapporti di affari con ambienti vicini alla Turchia e altri paesi mediorientali) che, come consigliere per la sicurezza nazionale, sarà l’autentico arbitro della politica estera; Mike Pompeo (esponente di spicco dell’ultradestra radicale, favorevole alla legalizzazione della tortura e grande oppositore dell’accordo nucleare con l’Iran) a capo della CIA.
Certo è che appare surreale il dialogo tra un uomo che procede per battutacce ed un raffinato diplomatico, per esempio russo, che è abituato a parlare per simboli o sottintesi e che, in ogni caso, suole occultare le vere motivazioni di ciò che dice. Per queste ragioni Trump tende a disertare le occasioni dei grandi convegni internazionali, dove si muoverebbe come un elefante in una cristalleria. Preferisce piuttosto gli incontri bilaterali, anche se presi alla lontana; vedi infatti i contatti con i capi di stato di Cina e Giappone, paesi in cui l’America ha grandi interessi, alcuni a suo carico di tipo finanziario, politico e commerciale, tutti però attualmente differibili. Nel concreto, per quel che indicano le prime intenzioni espresse, sembra che voglia alleggerire il fronte della NATO, cosa tutt’altro che semplice se si pensa che si tratta di una struttura militare che ha presenze di molto peso in quasi tutte le parti del mondo e che attualmente costa agli americani e ai loro alleati quasi 800 miliardi di dollari l’anno. Poi c’è l’avvicinamento dichiarato alla Russia di Putin, intenzioni che sembrano contraddittorie. Certo se effettivamente si verificasse un alleggerimento da parte dell’America della NATO, il vuoto che ne deriverebbe sarebbe immediatamente riempito dalla ingombrante presenza russa.
Ma l’avvicinamento alla Russia crea altrettanti problemi difficili da risolvere sul piano degli equilibri internazionali. C’è il fronte mediorientale, con la Russia che appoggia Assad mentre sin qui gli USA ha sostenuto i suoi oppositori. Da ciò, e dal conseguente annullamento degli aiuti ai militari curdi e a tutte le etnie che con questi militari hanno sin qui contrastato il fronte governativo della Siria, deriverebbe un mutamento degli equilibri politici dell’intero Medio Oriente, considerando anche che ancora non è chiaro cosa il leader americano intende fare circa il programma nucleare dell’Iran ed il sostegno statunitense alla causa irachena.
Tralasciamo per il momento il molto complesso fronte asiatico e gli enormi interessi che in quell’area si contrappongono. Si tratta di problemi assai complessi che non possiamo, nello spazio di un articolo, trattare specificamente.
Il nuovo assetto della Casa Bianca presenta molte prospettive assai inquietanti, tanto inquietanti che – come suo ultimo atto da presidente – Barak Obama si rivolge all’Europa per arginare la deriva del nuovo governo americano (alla Merkel ha chiesto esplicitamente di non allentare le sanzioni contro la Russia), auspicando che le circostanze inducano il nostro continente a realizzarsi come fronte politicamente coeso, idoneo a fronteggiare tale deriva e soprattutto a costituirsi come opposizione alle misure espansionistiche della Russia. Un atto, questo, che è quasi un disperato tentativo di difendere quel poco di socialmente rilevante che nel corso della sua amministrazione è riuscito a realizzare.
Antonio Cardella
lunedì, Febbraio 23, 2026